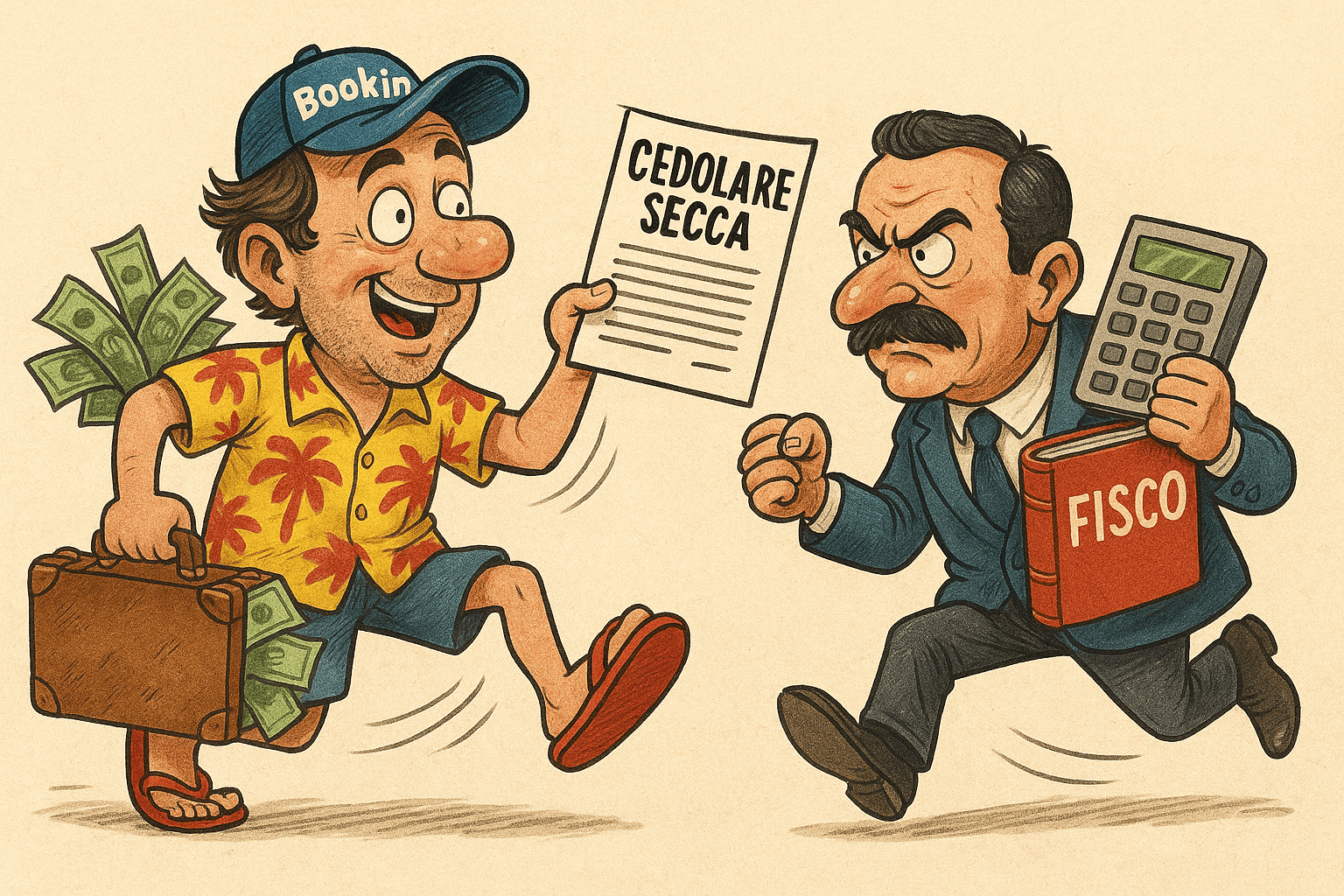La “cedolare secca” è tornata sotto i riflettori, questa volta con un colpo di scena che ha fatto tremare i server di Booking.com. La notizia è di quelle che fanno sorridere (amaro): il colosso olandese ha versato 312,5 milioni di euro allo Stato italiano, dopo anni di “dimenticanze” sulle ritenute del 21% applicabili agli affitti brevi. Una decisione clamorosa, frutto di un’indagine dell’Agenzia delle Entrate cominciata nel 2023. La keyphrase cedolare secca non è mai stata così attuale.
Ma attenzione: prima di stappare lo spumante, meglio leggere bene le note a piè di pagina di questa vicenda. Perché se è vero che l’Italia ha ottenuto un versamento importante, resta aperta la questione ben più corposa delle imposte sui profitti delle piattaforme digitali.
La saga delle piattaforme e la tassazione “intelligente”
Dal 2017 al 2023, Booking.com ha raccolto miliardi di euro in prenotazioni, fungendo da intermediario tra turisti e proprietari di casa. In teoria, avrebbe dovuto trattenere il 21% a titolo di ritenuta fiscale. In pratica, non lo ha fatto. Solo a seguito dell’indagine del 2023 ha scelto la via della “collaborazione”, evitando così guai giudiziari per i suoi dirigenti.
Ora Booking, da gennaio 2024, trattiene direttamente la cedolare secca e la versa allo Stato. È una semplificazione per gli host, spesso spaesati nel caos burocratico italiano. E un gesto “distensivo” verso le autorità fiscali italiane, anche se motivato più dal pragmatismo che dall’amore per la giustizia tributaria.
Una vittoria? Sì, ma clamorosamente parziale
L’Agenzia delle Entrate ha definito questo accordo una “piccola grande vittoria”. Ed è vero: mai prima d’ora un gigante digitale aveva pagato una cifra simile per adeguarsi al regime fiscale italiano sulle locazioni brevi. Ma è proprio qui che emerge l’altro lato della medaglia.
Booking, come Airbnb, ha la sede legale in Paesi a fiscalità vantaggiosa: Olanda e Irlanda. Le commissioni che incassano dai proprietari italiani, e su cui realizzano profitti enormi, non vengono tassate in Italia. Quindi lo Stato ha incassato le ritenute per conto degli host, ma ha rinunciato a una fetta ben più consistente dei ricavi delle piattaforme stesse.
In parole povere: gli host pagano, i colossi incassano, e le tasse su quei profitti volano verso Amsterdam e Dublino.
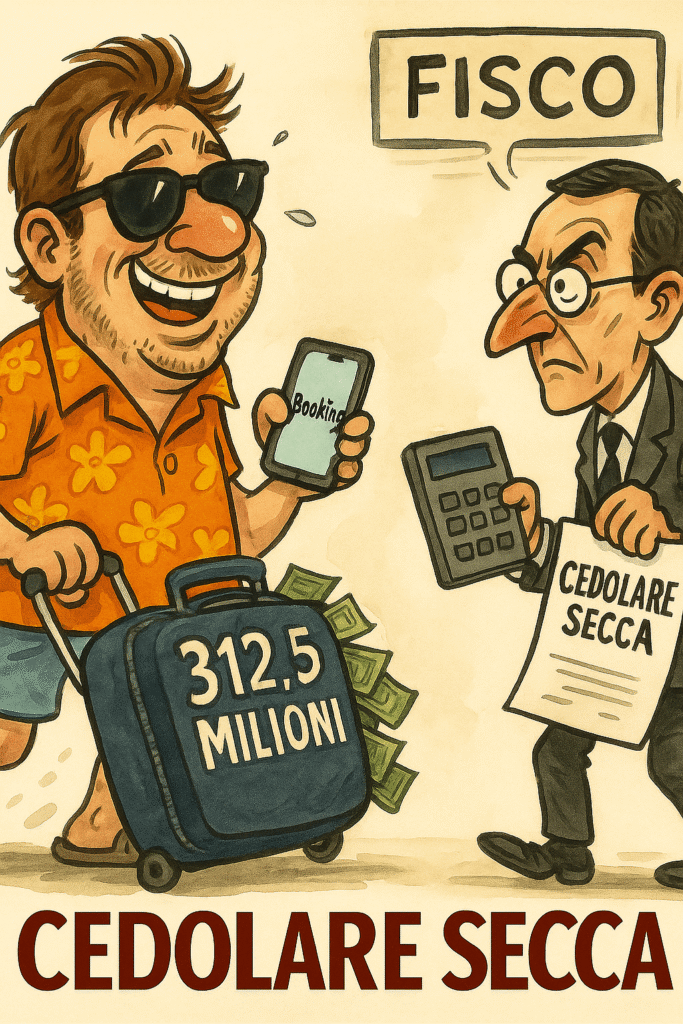
Host tra obblighi fiscali e assistenza virtuale
E per chi affitta? Un tempo si andava dal commercialista, o al massimo si inviava una PEC. Oggi, invece, i rapporti con Booking sono gestiti solo via chat o telefono. Nessun indirizzo legale in Italia, nessuna raccomandata possibile. Se c’è un errore nel codice fiscale o nella CU, arrangiati.
La DAC7 ha imposto nuovi obblighi di comunicazione, compresi i CIN (Codici Identificativi Nazionali), ma i canali di assistenza sono rimasti quelli della Silicon Valley: virtuali, standardizzati, impersonali. Il contratto tra host e piattaforma è spesso scritto in inglese, con foro competente in Olanda o Irlanda. Auguri se volete far valere i vostri diritti.
Cedolare secca e fiscalità digitale: un terreno in evoluzione
Il caso Booking rappresenta un precedente importante: lo Stato italiano può far valere le proprie leggi anche verso soggetti stranieri. Tuttavia, la strada per una fiscalità digitale davvero equa è ancora lunga. La Commissione Europea ha proposto soluzioni, come il Digital Services Act e il Digital Markets Act, ma l’efficacia resta da verificare.
Per ora, possiamo celebrare una mezza vittoria. E ricordare che, finché l’Europa non adotterà una posizione fiscale unitaria, i giganti del web continueranno a “scegliere casa” nei paradisi fiscali.